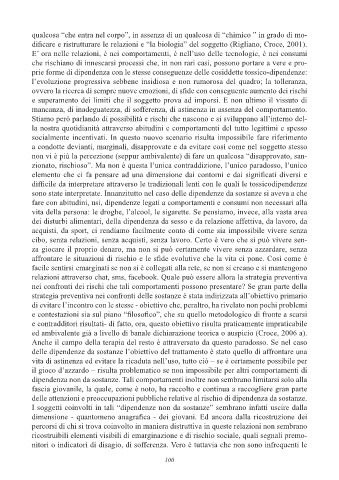Page 100 - Sipsot Libro Linee di Indirizzo_27_aprile
P. 100
qualcosa “che entra nel corpo”, in assenza di un qualcosa di “chimico ” in grado di mo-
dificare e ristrutturare le relazioni e “la biologia” del soggetto (Rigliano, Croce, 2001).
E’ ora nelle relazioni, è nei comportamenti, è nell’uso delle tecnologie, è nei consumi
che rischiano di innescarsi processi che, in non rari casi, possono portare a vere e pro-
prie forme di dipendenza con le stesse conseguenze delle cosiddette tossico-dipendenze:
l’evoluzione progressiva sebbene insidiosa e non rumorosa del quadro; la tolleranza,
ovvero la ricerca di sempre nuove emozioni, di sfide con conseguente aumento dei rischi
e superamento dei limiti che il soggetto prova ad imporsi. E non ultimo il vissuto di
mancanza, di inadeguatezza, di sofferenza, di astinenza in assenza del comportamento.
Stiamo però parlando di possibilità e rischi che nascono e si sviluppano all’interno del-
la nostra quotidianità attraverso abitudini e comportamenti del tutto legittimi e spesso
socialmente incentivati. In questo nuovo scenario risulta impossibile fare riferimento
a condotte devianti, marginali, disapprovate e da evitare così come nel soggetto stesso
non vi è più la percezione (seppur ambivalente) di fare un qualcosa “disapprovato, san-
zionato, rischioso”. Ma non è questa l’unica contraddizione, l’unico paradosso, l’unico
elemento che ci fa pensare ad una dimensione dai contorni e dai significati diversi e
difficile da interpretare attraverso le tradizionali lenti con le quali le tossicodipendenze
sono state interpretate. Innanzitutto nel caso delle dipendenze da sostanze si aveva a che
fare con abitudini, usi, dipendenze legati a comportamenti e consumi non necessari alla
vita della persona: le droghe, l’alcool, le sigarette. Se pensiamo, invece, alla vasta area
dei disturbi alimentari, della dipendenza da sesso e da relazione affettiva, da lavoro, da
acquisti, da sport, ci rendiamo facilmente conto di come sia impossibile vivere senza
cibo, senza relazioni, senza acquisti, senza lavoro. Certo è vero che si può vivere sen-
za giocare il proprio denaro, ma non si può certamente vivere senza azzardare, senza
affrontare le situazioni di rischio e le sfide evolutive che la vita ci pone. Così come è
facile sentirsi emarginati se non si è collegati alla rete, se non si creano e si mantengono
relazioni attraverso chat, sms, facebook. Quale può essere allora la strategia preventiva
nei confronti dei rischi che tali comportamenti possono presentare? Se gran parte della
strategia preventiva nei confronti delle sostanze è stata indirizzata all’obiettivo primario
di evitare l’incontro con le stesse - obiettivo che, peraltro, ha rivelato non pochi problemi
e contestazioni sia sul piano “filosofico”, che su quello metodologico di fronte a scarsi
e contradditori risultati- di fatto, ora, questo obiettivo risulta praticamente impraticabile
ed ambivalente già a livello di banale dichiarazione teorica o auspicio (Croce, 2006 a).
Anche il campo della terapia del resto è attraversato da questo paradosso. Se nel caso
delle dipendenze da sostanze l’obiettivo del trattamento è stato quello di affrontare una
vita di astinenza ed evitare la ricaduta nell’uso, tutto ciò – se è certamente possibile per
il gioco d’azzardo – risulta problematico se non impossibile per altri comportamenti di
dipendenza non da sostanze. Tali comportamenti inoltre non sembrano limitarsi solo alla
fascia giovanile, la quale, come è noto, ha raccolto e continua a raccogliere gran parte
delle attenzioni e preoccupazioni pubbliche relative al rischio di dipendenza da sostanze.
I soggetti coinvolti in tali “dipendenze non da sostanze” sembrano infatti uscire dalla
dimensione - quantomeno anagrafica - dei giovani. Ed ancora dalla ricostruzione dei
percorsi di chi si trova coinvolto in maniera distruttiva in queste relazioni non sembrano
ricostruibili elementi visibili di emarginazione e di rischio sociale, quali segnali premo-
nitori o indicatori di disagio, di sofferenza. Vero è tuttavia che non sono infrequenti le
100